Le Divergenze Celesti - Gianfranco Depalos
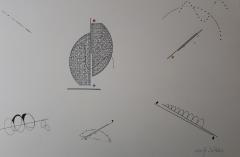
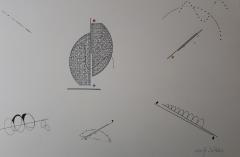

Ogni cosa in questo mondo ha in se la capacità potenziale di produrre suggestione, emozione e sentimento, basta saperli cogliere: Mughini in un suo racconto osservava “ la mia poltrona fa parte di me; su quella poltrona ho meditato, ho sognato, ho urlato, ho pianto” , quando la guardo vedo in lei tutto il mio passato, la mia gioventù, la mia speranza, tutte le delusioni ed il dolore di alcuni giorni. Le arti nelle loro infinite espressioni, figurativa, musicale, teatrale, fotografica , cinematografica ecc , ed il mondo virtuale sono in grado di indurre suggestioni, emozioni e sentimenti con grande effetto, ma ciò avviene se riescono a narrare nei diversi contesti con un appropriato dominio dei suoni, dei toni, dei colori e delle tecnologie, in buona sostanza di tutto ciò che è in grado di emozionare e lasciare un segno in ciascuno di noi. Per ognuna di esse esistono tecniche specifiche frutto di una lunga e collaudata esperienza, sempre in evoluzione.
Il poeta, scrittore e critico letterario Domenico Adriano ha intervistato i finalisti del Premio FEDERICA GIORDANO - GIANCARLO PONTIGGIA - GIUSEPPE GRATTACASO
Presentazione del libro "Ciò che appare nello specchio - viaggio nel mondo islamico a cura del giornalista critico letterario Arnaldo Colasanti presso La Nuova Pesa, primario circolo culturale di Roma. L'eredità più riconosciuta di Henry Corbin è quella dell'orientalista che ha fatto scoprire insospettate e ricche tradizioni spirituali-filosofiche dell'Iran sh?'ita. Nel presente lavoro ci si è sforzati tuttavia di tenere assieme l'opera dell'esegeta e del fenomenologo della religione con quella del filosofo teoreticamente in grado di interrogare da un altro luogo i percorsi della metafisica occidentale sui temi centrali dell'essere e dell'"essere immagine" VIDEO

Gabriele (D’Annunzio è il cognome di uno zio adottivo, che peraltro gli piace sentendosi l’Arcangelo annunciatore alle genti), figlio di Francesco Paolo Rapagnetta e Luisa De Benedictis, si dimostra allievo diligente, primeggiando negli studi. Il collegio che frequenterà a Prato nella colta terra toscana, correggerà la sua inflessione dialettale e lo preparerà ad una disinvoltura linguistica. Le chiare attitudini letterarie gli fanno ben presto privilegiare la poesia e Carducci come poeta-vate, in quanto egli stesso si sente predestinato a questo ruolo-vate per il destino della nazione e come celebratore degli eroi. A soli sedici anni, anche per il sostegno economico del padre, contento dell’affermazione di questo figlio prodigio, pubblica Primo vere con grande consapevolezza poetica, compenetrato già in una ricercatezza di stile, che gli sarà del resto consona in tutte le sue produzioni artistiche. Primo vere non sarà altro che l’inizio di una prolifica e poliedrica produzione letteraria, che vede un alternarsi di testi in poesia e prosa, come giornalista, novelliere, romanziere e drammaturgo. In maniera più singolare si potrebbe dire, però, che è la prima guerra mondiale a segnare una divisione nelle opere e nelle gesta di questo scrittore soldato, di questo poeta eroe. Fanno parte del primo momento che vede più preponderante lo scrittore-poeta: Canto novo, L’Isotteo e la Chimera, Elegie romane, Poema paradisiaco, Odi navali, Intermezzo, Laudi, Il piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no, La Leda senza cigno, Sogno di un mattino di primavera, La città morta, Sogno d’un tramonto di autunno, La Gioconda, La gloria, Francesca da Rimini, La figlia di Jorio, La fiaccola sotto il moggio, Più che l’amore, La nave, Fedra, Le martyre de Saint Sebastien, La crociata degli innocenti, La pisanella, Parisina, Il ferro. Appartengono invece, al secondo momento dello scrittore-soldato: Canzoni delle gesta di oltre mare, Per la più grande Italia, Notturno, La canzone del Quarnaro, Faville del maglio, Canti della guerra latina, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’Annunzio tentato di morire, ed ancora i tantissimi discorsi, proclami. Intelligente, spregiudicato cerca con tutti i mezzi notorietà, come quando, in concomitanza alla sua prima pubblicazione, dà ai giornali l’annuncio della sua morte, consapevole che una tale notizia, gli avrebbe portato consenso, come del resto accadde, nel costruirsi un’immagine pubblica. Per lo stesso motivo ama circondarsi di personalità e tale è già il pittore Francesco Paolo Michetti, che diventa suo amico, o la duchessina di Gallese Maria Hardouin, che diventa sua moglie. Una vita prepotentemente all’insegna del clamore, tra sperpero di denaro, amori che vanno e vengono, e in questo non dissimile da suo padre che aveva lasciato la famiglia in disastrosa situazione economica. Consapevole che la poesia non “dà pane” si costringe ad un lavoro di giornalista, ma solo per breve tempo, perché insoddisfatto torna a soli venticinque anni a scegliere di essere letterato, lasciata la moglie e i tre figli. Di lì a seguire sarà solo scrittore, anche perché “nutrito di tanta cultura”, Carducci, Capuana Verga, Flaubert, Maupassant, Zola, Baurget, Barrès, Dostojevsky, sono i suoi riferimenti letterari, che peraltro lo sollecitano ad un superamento del naturalismo, realtà precipua della sua prima opera, per accostarsi ad una introspezione psicologica, che caratterizza sempre più i primi anni del Novecento. L’affermazione di un Decadentismo alla ricerca di miti umani, dettati da scrittori e pensatori come Nietzche, diventeranno altrettanto grandemente significativi per il giovane scrittore. E’ proprio in queste forme decadentistiche che D’Annunzio si identifica col suo ideale di Bellezza e di Forza, nel cantare la natura della sua terra natale, nonché la sua Patria in uno spirito glorioso e sensuale. Sensualismo che gli fa privilegiare le condizioni poco comuni e che travasa nelle sue opere o che talvolta tralascia per intenti politici e irredentistici, delineando la teoria del Superuomo, di un eroe privo, perché no, anche di intenti morali, inteso come è alla violenza e alla forza pur di affermare i suoi istinti. Queste immagini lasciano talvolta un senso di vuoto. L’irrequietezza del suo pensare e del suo agire frastorna e ci rende estranei, ma il più delle volte ci coinvolge, perché la crudeltà come il tramonto, un delitto come un viaggio o una battaglia, fanno parte della vita. La visione “panica” che lo scrittore confronta con il suo stile rivestito di perfezione formale, rende la sua espressione artistica più intensa e stempera la virilità che gli è altrettanto propria e naturale. In questo concerto di sensualismo, naturalismo e di naturalismo sensuale, si raccorda il mito del Superuomo dannunziano di cui si farà interprete ed eroe nella difesa di quella “Vittoria mutilata”, espressione da egli stesso coniata per indicare quella vittoria militare ottenuta in battaglia e vilipesa nelle trattative diplomatiche. D’Annunzio forte della sua vitalità, non era nuovo alle azioni politiche e alla causa italiana: infatti era già stato eletto, come uomo di destra, deputato per la ventesima legislatura del 1897. Aveva profuso tutte le sue energie per la sua riuscita elettorale, come egli stesso aveva testimoniato: “…Torno ora da un giro elettorale ed ho ancora piene le nari di un acre odore umano. Questa impresa può sembrare stolta ed estranea all’arte mia e contraria allo stile di vita mia, ma per giudicare la mia attitudine bisogna attendere l’effetto a cui la mia volontà tende direttamente…”. E, non coerente alla vita politica, ma coerentemente alla vitalità della sua fervida vita, in occasione delle leggi repressive proposte da Pelloux, non si esenta dal sottrarsi a critiche e commenti, passando alla sinistra al grido di “…Passo verso la vita!”. Ed è sempre in questo alternarsi di affermazione artistica e di soldato-eroe, che non è estraneo ad imprese di patriota italiano, quando nel maggio del 1915 predica l’intervento dell’Italia in guerra con accesi discorsi “Per la più grande Italia”: si fa volontario non risparmiandosi nel 1917 come soldato sulle montagne del Carso; come aviatore su Vienna, Pola e Cattaro all’insegna di quel grido greco-romano, da egli stesso riproposto: “Eia, eia, alalà”; subendo il distacco della retina di un occhio in seguito ad un atterraggio rischioso; privilegiando con il suo MAS imprese quali “La beffa di Buccari” del 1918, quando entra nel golfo del Carnaro per gettare in mare bottiglie contenenti messaggi oltraggiosi per il nemico, o quando volando su Vienna, invece di bombe, lancerà volantini per invitare i nemici ad arrendersi. Autocelebrando comunque le proprie imprese in termini sublimi e di eroismo, perché ormai “il dandy” si è trasformato in un superuomo che subordina tutto all’affermazione: Ritornato viene accolto come un valoroso e da qui rinforza il gusto per il gesto eccezionale, spettacolare inimitabile. Il mito dell’eroe, del superuomo non è, però, una condizione dannunziana, visto che già nel seicento e poi con Goethe c’era stato l’anelito da parte delle persone di superare mi propri limiti. L’accezione razzista-nazionalista, testimoniata dal nazismo è però dell’età del poeta. Uomo d’azione, intrepido sostenitore dell’Istria e della Dalmazia in Italia, ma è con l’impresa di Fiume che renderà perenne nel tempo la sua immagine, perché Fiume è per D’Annunzio, come dice in una lettera a Don Rubino suo amico, “Causa Santa…la più pura e la più alta che sia nel mondo …merita…non soltanto la vita, che è lieve, ma ogni altro bene…Io non lascerò Fiume se non morto. Ma neppure morto, ché desidero riposare in vista del Quarnaro, all’ombra di quei lauri”. Del resto, sollecitando già i marinai d’Italia in Fiume italiana e tutti i marinai d’Italia nell’Adriatico italiano, con un fare estetico-politico aveva tratteggiato quell’Adriatico a lui tanto caro perché “… E’ sempre stato per noi un mare di vita perché ci appariva come una forma della nostra passione e come una forma della nostra speranza. Era nostro perché non avevamo mai cessato di volerlo nostro…”. E’ un amplesso sensualistico panico di superomismo quello del poeta nei confronti di Fiume e della Dalmazia, che i trattati della prima guerra mondiale non avevano riconosciuti assegnati all’Italia. Tanto sangue sparso non era riuscito a riscattare l’italianità di un popolo che si era sentito italiano da sempre. Questione fiumana (12 settembre 1919) Aspetto geografico Fiume si sviluppò come città ad ovest del fiume Eneo, corso d’acqua di origine carsica ricco e inesauribile. Porto estremo della Venezia Giulia, situato tra la penisola Appenninica e la Balcanica, si affaccia sul Golfo del Carnaro. Nell’era prebellica la città fu ricchissima di industrie e porto importantissimo. Per questa condizione fortunata nel secolo XIX sorse sul territorio limitrofo politicamente croato una città nuova, Sussak che ne limitò l’economia e l’espansione. Aspetto storico Nel 60 a.C. in questo territorio troviamo un insediamento dei romani: sono di questo periodo notizie di un’area chiamata Tarsatica, centro abitato al di là della fiumara. Nel XIII secolo al posto del nome Tarsatica, come terra fluminis, diventa Fiume. Alla fine dell’impero carolingio passò sotto i Vescovi di Pola, poi sotto i Signori di Duino, i Frangipane e i Conti di Walsee (1400). Nel 1466 sotto il sovrano Federico III d’Asburgo. Venezia la sentiva rivale già da quando si era resa “Libero Comune”; la situazione peggiorò quando scoppiò il conflitto tra Massimiliano di Asburgo e Venezia (Lega di Cambrai). Nel 1627 era dei Gesuiti e in questo periodo ancor più si diffuse la cultura latina e italiana. Successivamente Fiume riuscì a farsi riconoscere autonoma: Maria Teresa volle sottoporla a Trieste ma dovette fare marcia indietro. Nel 1776 divenne porto dell’Ungheria, tramite la Croazia, ma i fiumani protestarono e Maria Teresa la rese autonoma dalla Croazia stessa. Nel 1779 fu riconosciuta “Corpus Separatum” perché annessa alla corona ungarica senza mediazione. Successivamente subì il dominio napoleonico e austriaco e nel 1822 Fiume ritornò alla corona ungarica, cosa gradita ai fiumani perché l’Ungheria da sempre aveva rispettato la lingua, le tradizioni e le istituzioni italiche della città. Nel 1848 la Croazia in seguito ai disordini dell’Ungheria occupò Fiume, cercando di croatizzarla: le opposizioni dei notabili fiumani incoraggiarono l’Ungheria alla riannessione e i croati dovettero accettare tale soluzione (1870). Dopo il ritorno di Fiume sotto gli ungheresi, essi imposero il proprio dominio, ma i fiumani che nei tempi per lingua e costumi, si erano sentiti sempre italiani, cominciarono a pensare all’Italia come Patria e quando scoppiò la prima guerra mondiale, mettendo a confronto l’impero austroungarico e l’Italia stessa, la maggior parte dei fiumani, eccetto gli autonomisti ed i panslavisti scelsero l’Italia. L’Italia era intanto entrata in guerra con delle richieste condivise dall’Intesa, ma il Patto di Londra (26-4-1915) aveva assegnato il porto di Fiume ad altro Stato; nel Trattato di Parigi (10-9-1919) l’Italia reclamò Fiume, ma la neonata Jugoslavia chiese i territori che il Patto aveva assegnato all’Italia, quindi l’Istria, Trieste e la Dalmazia tutta, mentre la Francia e l’Inghilterra negavano l’annessione di Fiume e Wilson, in nome degli Stati Uniti chiedeva all’Italia la rinunzia alla Dalmazia e di Fiume, ma i fiumani si mobilitarono per ottenere l’annessione all’Italia. La Conferenza di Parigi ridusse il contingente italiano nei territori adriatici orientali occupati dopo la vittoria; Gabriele D’Annunzio, animato da fiero spirito nazionalistico e i suoi legionari (nome da lui stesso dato dai soldati a cui si era messo a capo), decisero allora l’occupazione della città (Marcia di Ronchi 12-9-1919), dando luogo alla questione fiumana, in opposizione alle decisioni del governo italiano, determinando una sedizione contro lo Stato stesso. Così facendo D’Annunzio rivendicava quel ruolo di poeta-vate a cui si era sempre sentito chiamato, in virtù di quel superomismo che era diventato la sua fede e di cui viveva l’evoluzione, svincolato da ogni remora etica. D’Annunzio, del resto, era convinto che solo lui, che aveva appoggi dall’Italia, dai paesi alleati e dall’America, avrebbe potuto risolvere tale questione. Tra l’altro con questa scelta non fece che avvalorare lo scopo che aveva perseguito per tutta la vita “votarsi alla gloria”. Un esercito di arditi sempre più numeroso, lo sostenne in questa impresa, condivisa tra l’altro dal politico Benito Mussolini ormai alla guida del partito fascista. Per il poeta-soldato non era, del resto, una condizione nuova dilatare la vita alla legge del “vivere o morire”, “gioia o morire”, nel voler dominare il mondo con il suo istinto, con quel superomismo appunto con il quale tutto è, tutto gli è permesso. E la vita dell’eroe diventa l’essenziale del suo pensiero e non soltanto per le sue opere letterarie. Intanto mentre gli alleati si allontanavano, i fiumani gli affidarono i pieni poteri. Wilson cercò di rendere Fiume Stato indipendente, mentre Nitti tra tentennamenti e ipocrite dichiarazioni prometteva di risolvere la questione. La Iugoslavia, questo nuovo regno dei Serbi, Croati e sloveni (SHS), disattesa da lui come Stato e intesa come una specie di “Malebolge terrestre”, respingeva le pretese italiane di una indipendenza della città. D’Annunzio assumendo i poteri civili rimessigli dal Consiglio Nazionale, proclamò la Reggenza Italiana delineata nella Carta del Carnaro e sostenuta dalla volontà dei fiumani, che con il Proclama del 30 ottobre 1918 avevano già dichiarato liberamente “la dedizione piena e intiera alla madre patria”. Il Trattato di Rapallo del 1920 rendeva, però, Fiume stato indipendente e libero, per ottemperare a quanto stabilito negli accordi internazionali. D’Annunzio e i fiumani non riconobbero il Patto e, alla vigilia del Natale 1920, Fiume fu bombardata dalle navi italiane per ordine del Regio governo. “Il Comandante” nel disperato tentativo di evitare il tragico scontro civile, aveva fatto lanciare dagli aerei fiumani dei volantini sulle truppe del generale Ferrario, recitanti: “Ai fratelli che assediano i fratelli” “…Le vostre madri non sanno che voi siete per compiere il fratricidio. Non sanno che voi martoriate una città non colpevole se non d’aver sempre sofferto per l’Italia, se no d’aver sempre creduto nell’Italia, se non d’esser sempre fedele all’Italia…”. Ed ancora compiute le tragiche giornate del “Natale di sangue”, dove lui stesso fu ferito da calcinacci alla testa ed altri compagni morirono, fece lanciare foglietti volanti su Trieste e Venezia “… il delitto è consumato. La terra di Fiume è insanguinata di sangue fraterno…”. Bellissime e dolorosissime sono le pagine di prosa “Commento tra le tombe” redatte dal poeta per l’evento. D’Annunzio per un cuor patrio che lo chiamava al rispetto dei fiumani, temendo la minaccia della distruzione dei suoi abitanti e della città, decise di lasciare Fiume nella piena libertà d’azione e si dimise rinunciando al comando dei legionari, consapevole di essere stato l’interprete di uno dei momenti più drammatici della nostra storia presente. Fiume ebbe un governo provvisorio retto dal dannunziano Antonio Grossich. Il trattato di Rapallo aveva riconosciuto ai croati Porto Baross, condizione che comportò a Fiume molti disordini per le prevedibili, disastrose conseguenze economiche, ma questo sacrificio era inteso come tributo per l’annessione all’Italia proposta da Mussolini e confermata con il Patto di Roma (27-1-1924). Quel Mussolini che con un colpo di stato con la Marcia su Roma si era garantito il governo, marcia che D’Annunzio non aveva partecipato, pur avendola egli stesso preparata, nella convinzione che questi sarebbe stata solo una meteora di poco conto e tempo. Qui il suo grande errore, perché “il Duce”, pur strumentalizzando la sua figura come poeta ufficiale del fascismo, lo relegò sempre più fuori della vita politica, temendolo come potenziale avversario. D’Annunzio, però, si terrà fuori dalla mischia di quel movimento che pure aveva precorso, allontanandosene ora, non condividendone tutti i punti del programma. Come l’araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, si dedicherà alla costruzione della sua casa museo sul Garda con i contributi dello Stato, casa che renderà maestosa e bizzarra nella sua ricerca esasperata di estetismo come aspirazione al sublime, nonché autocelebrativa per magnificare la sua persona: sarà il suo lascito agli italiani, come si evince dall’incisione sul portale d’accesso: “Io ho quel che ho donato”, coerente fino alla fine al suo ideale di persona superomistica, compromessa però da un senso di stanchezza e di morte, condizione che renderà più meditative le sue riflessioni autobiografiche o riguardanti la guerra, determinando il superamento della tensione superomistica stessa e confermandolo poeta più sensibile in questa vulnerabilità della sconfitta. Sprezzante della volgarità della massa, nella sua condizione aristocratica, antidemocratica e di ricerca di sensazioni raffinate, diventato egli stesso fenomeno di massa, determinando il suo successo con una capacità di intuire in anticipo i gusti del pubblico, adeguandovisi: ‘fatto di costume’, modello da imitare da parte di quella piccola borghesia che, incarnandosi in lui, evadeva una realtà meschina diventando a sua volta superomistica; fu già dai suoi contemporanei tanto amato quanto rifiutato. Ancora oggi i critici talvolta l’osannano per le sue atmosfere letterarie, magiche e musicali e le sue imprese eroiche; talvolta lo disprezzano per la sua scarsità intellettuale di spirito critico, di profondità mistica per quelle stesse imprese di guerra da lui composte. Certo è che oggettivamente, al di là di un suo recondito pensiero del fare, rimane il poeta-soldato che ha difeso, pur rischiando la sua vita, davanti a tutto il mondo intero l’italianità e l’Italia stessa, commuovendoci con il lasciarci sofferte e toccanti pagine patriottiche, monito alle generazioni future per un recupero ed un appropriamento delle proprie radici e dell’italianità stessa.

Poesia e aforisma, due parole che, accostate, possono apparire un ossimoro. Eppure Lidia Sella, artista di comprovato talento, opera addirittura superando il semplice accostamento e, con scelta innovativa quanto ingegnosa, ci regala, attraverso la fusione dei due generi, splendidi “poesismi”, illuminazioni intuitive, lampi di verità che vanno ben oltre gli schemi abituali. E questo senza smettere mai, filosoficamente, di interrogarsi. Di ricercare. “Pensieri superstiti” diventa allora un nuovo modo di comunicare l’ispirazione nella sua vastità facendone sintesi di bellezza, e questo grazie a una scrittura innovativa e colta, diretta ed evocativa, pronta a svolgere un ruolo che oseremmo definire didattico. Perché la mente, come affermava Plutarco, non è un vuoto da riempire, ma un fuoco da accendere. MARIA ROSARIA PERILLI
L’aforisma come genere oscilla tra il compimento e la catastrofe, la pienezza e la lacerazione. Questa duplicità, così bene indicata da Robert Musil e da Ferruccio Masini, è implicita nel suo essere al tempo stesso unità e frammento, pienezza e mancanza. L’aforisma chiede aiuto e cela nella sua apparente perentorietà questa radicale necessità esistenziale. Gli aforismi di Lidia Sella sono frecce e pungoli, denunciano e procurano ferite che possono far male ma anche risanare, chiedono aiuto e pure lo offrono. Nella nostra meditazione contemporanea sono punti di vista con cui è bene confrontarsi. Come scriveva Bacone, il genere dell’aforisma è per sua stessa natura dialogico, gli spazi bianchi chiedono di essere riempiti da altre voci, siano esse in sintonia o in contrasto. L’aforisma rifugge l’omogeneità. In quest’ottica le massime di Lidia Sella possono essere taglienti e fertili pietre di paragone. GINO RUOZZI

Premio Frascati Giovani Ugo Reale 2019 - Raccontare "L'uomo sulla luna" tra musica e poesia 1969-2019 -PartecIpano gli studenti degli Istituti Comprensivi di Frascati e di Roccamonfina /Galluccio con l'astrofisico Marco Castellani e Chiara Fiumi - Conduttrici Rita Seccareccia e Mirella Tribioli - AUDIO


Gabi (in lingua latina Gabii) fu una città del Latium vetus, posta al XII miglio della via Prenestina, che collegava Roma a Præneste, e che secondo Dionigi di Alicarnasso faceva parte della Lega Latina. Le sue cave fornivano un'eccellente pietra da costruzione, il lapis gabinus. Secondo la tradizione fu il luogo dove Romolo e Remo sarebbero stati educati e sarebbe stata loro insegnata la scrittura. A Gabi si rifugiò Tarquinio il Superbo, quando fu espulso dall'Urbe dai cittadini in rivolta che avevano decretato la fine della monarchia e l'esilio perpetuo. Gabi rappresenta il vertice antico di un triangolo con ai lati le cittadine di Tibur (Tivoli), Præneste (Palestrina) e Collatia ( Lunghezza), che nel periodo antico ebbero notevole sviluppo e grande importanza nelle vicende storiche e politiche del Lazio in forza della posizione strategica sulle arterie di collegamento dei percorsi commerciali tra l'Etruria e la Campania. Tra il IX secolo a.C. e VIII secolo a.C. in queste comunità ebbero luogo delle trasformazioni sociali, che portarono alla costituzione di un sistema sociale con la formazione di centri protourbani, anticipatori di quelli urbani propri del territorio laziale latino. Gabi potrebbe essere la città natale del poeta Tibullo. Il sito, che si trova adesso a circa 20 chilometri di distanza da Roma al km 2 della via Prenestina Nuova, era situato lungo il percorso della via Prenestina antica, che attraversava la città, formando l'asse viario principale, via che in precedenza era chiamata via Gabina ( o Gabiense). NEL grande lago prosciugato che costeggiava Gabi, il lago di Castiglione, adesso spuntano balle di fieno, i trattori procedono pigri nel loro andirivieni e il podere quattrocentesco in cima alla collina è rosa e nuovo, con un magazzino dove cassette e cassette di cocci vengono spazzolate, lavate e talvolta ricomposte in anfore o vasi. Sparsi nella campagna intorno - tra il grano, i papaveri e le margherite - tanti ruderi apparentemente indistinti. Sul bordo della conca verde che era stata un vulcano e poi un lago, sta una manciata di case impari, senza ordine né regola, borgate col nome di Osa e Castiglione d' Osa. E' qui, dietro la via Prenestina nuova, al fianco di Pantano Borghese, che sorgeva l' antica Gabii, cittadina potente, al centro di un crocevia di scambi con la Campania di Cuma e l' Etruria di Cerveteri, dai costumi raffinati tanto da generare una leggenda secondo la quale Romolo e Remo vi vennero inviati per la loro formazione. Qui era Gabii, famosa per la sua pietra capace di resistere agli incendi a cui deve forse anche il toponimo, che potrebbe venire da cabum-cavum, luogo delle cave di pietra. Utilizzata per costruire il grande muro che separa la Suburra dal Foro di Augusto, per Ponte Milvio, per la tomba di Cecilia Metella. Gabii, la nemica di Roma ai suoi albori che al solo nominarla destava allarme e preoccupazione. Sono tante le leggende, innumerevoli le attestazioni nei testi dei grandi autori classici che dicono la storia di questa che in origine era, come quasi tutte le città del Latium vetus, una colonia di Alba Longa. Della storia successiva, delle sanguinose lotte per la supremazia parla Dionigi di Alicarnasso e poi ancora Tito Livio. Ma la più nobile delle fonti è Virgilio che nel libro VII dell' Eneide fa menzione del santuario di Giunone gabina quando racconta le fondazioni delle città. E Marziale elogia negli epigrammi i benefìci legati alle terme dove anche Augusto, imperatore della pace, veniva inviato dal suo medico, Antonio Musa Ma anche la storia degli scavi sull' area è corposa. A mettere le mani sulla terra è per primo Ennio Quirino Visconti insieme al principe Camillo Borghese che nel 1792 riconosce la piazza, l' antico foro ed estrae una quantità di statue, vasi, marmi, iscrizioni. Una collezione che viene poi collocata nel Casino dell' Orologio a piazza di Siena, nato per essere Museo Gabino ma destinato a una triste sorte giacché i reperti vennero ceduti a Napoleone Bonaparte e si trovano tuttora al museo del Louvre La necropoli di Osteria dell'Osa La necropoli dell'età del ferro di Osteria dell'Osa è legata con la fiorente Gabi, Le datazioni dei ritrovamenti si situano nel periodo compreso tra il IX e il VI secolo a.C.; la necropoli è composta da circa 800 tombe e sepolture. Nei ritrovamenti vi sono iscrizioni in lingua greca del 650 a.C., le più antiche in Italia in questa lingua (dopo la coppa di Nestore), ed iscrizioni in lingua latina del 750 a.C., che sono le più antiche del mondo in questa lingua. Presso la sezione della protostoria dei popoli latini del Museo nazionale romano sono raccolti i materiali scavati negli ultimi decenni. Quindi il valore strategico della posizione occupata da Gabii, il controllo di rilevanti arterie di collegamento e di tracciati commerciali (ad esempio tra l’Etruria meridionale e la Campania o tra il versante Adriatico) consentono alla città Gabina un notevole sviluppo economico, sociale e politico nella dimensione centrale pre-italica. Difatti nei primi decenni del V secolo a.C., quando Roma sconfisse la Lega Latina (costituita da alcune città che volevano mantenere la propria indipendenza) in prossimità di Gabi ( battaglia del lago Regillo), quest’ultima assunse una potenza e uno splendore mai più eguagliati. L’attività organizzativa e vitale ben nota anche nelle fonti classiche, è ricordata accuratamente dalle narrazioni di Dionigi di Alicarnasso, che menzionava l’invio a Gabi dei giovani Romolo e Remo, presso la comunità del pastore Faustolo, per apprendere, appunto, l’arte della scrittura e delle lettere, della musica e soprattutto dell’utilizzo delle armi. RILESSIONI Faustolo ed Acca Larentia: un pastore ed una prostituta. Quindi secondo la storiografia prevalente romana i figli di una regina, discendente da Enea, Rea Silvia, e del dio Marte, furono formati a Gabii da queste due figure: ACCA LARENZIA (Larentia, altri Laurentia). - Antichissima divinità romana, sulla cui tomba al Velabro il 23 dicembre, giorno dei Larentalia, il flamen Quirinalis e i pontefici celebravano sacrifici funebri (parentatio). Per alcuni (p. es. De Sanctis) essa è la madre dei Lari; altri invece, per la diversa quantità di Lăres e Lārentia, la ritengono una figura Magna Grecia, fusa poi con la divinità del Velabro (Zielinski, Wissowa); per altri infine essa sarebbe la Madre Terra. ( Treccani) ACCA LARENTIA E FAUSTOLO In Acca Larenzia e Faustolo si mescolano mito e leggenda. Da un lato, essa è, un antichissima dea etrusca, acquisita dai Romani come prostituta semidivina protettrice dei plebei. Dopo aver passato una notte di preghiere nel tempio di Eracle, per volere del semidio incontrò un uomo ricchissimo che sposatala, la lasciò erede di una immensa fortuna, che a sua volta lasciò al popolo romano, che festeggiava la donazione con le feste dette Larentali, ricorrevano il 23 dicembre. Più tardi il nome di Acca Larenzia fu attribuito alla moglie del pastore Faustolo che aveva trovato Romolo e Remo. Pur essendo già madre di dodici figli, i cosiddetti fratres arvales, Acca Larenzia allattò e allevò anche Romolo e Remo. La formazione di un’articolata “leggenda” riguardo alla fondazione di Roma conobbe un decisivo impulso in età augustea. Le ragioni di questo sviluppo sono abbastanza chiare: Roma era ormai diventata il centro politico, economico e culturale di tutto il Mediterraneo e Augusto, nella sua vasta opera di riorganizzazione della compagine statale romana, mirava ovviamente a nobilitarne il passato e a dare così ragioni “culturali” del suo dominio sul mondo. Il simbolo su cui si incentra la leggenda è la lupa, divenuta nume tutelare di Roma; la lupa era anche l’animale sacro del dio sabino Mamers, analogo di Marte, ed era anche l’animale tutelare dei latini con il nome di Luperco, mentre per gli etruschi il lupo raffigurava Aita il dio purificatore e fecondatore. Si può supporre che la fusione dei miti sia stata voluta per avere una maggiore coesione tra le diverse etnie. Tutta la simbologia appare incentrata sulla figura dell’animale meglio conosciuto da genti che vivevano di pastorizia e che esorcizzavano i loro timori assegnando al loro potenziale nemico attributi divini. Nella religione primitiva questi animali, lupi ma anche serpenti, rapaci ed i primitivi uri potevano dare la morte ma erano i figli della Dea Madre che era capace di rigenerare ogni cosa. Il culto della Dea Madre era associato ad una caverna che simboleggiava la parte interiore della dea da cui si generava la vita e la grotta dove la lupa portò al riparo i gemelli si chiamò Lupercale. ARVALI (fratres arvāles) Antico collegio sacerdotale romano, di dodici membri, che secondo una remotissima tradizione rappresentavano i dodici figli di Acca Larentia, e di Faustolo e in cui i mitografi riconoscevano una raffigurazione dei dodici mesi. Si dedicavano al culto della terra che nutrisce, invocandola sotto il nome di dea Dia, e il loro anno liturgico, che era anche l'anno di carica dei dignitarî del collegio, andava da una festa delle sementi all'altra Le origini degli Arvali si ricollegano con quella forma della primitiva religione che si riferisce alla coltura dei campi (arva), favorendola con cerimonie sacrificali. La dea Dia, che essi veneravano, era forse la stessa Cerere, e l'insegna propria dei membri del sodalizio era la corona di spighe con bianche bende. I solenni sacrifici dei fratelli Arvali si celebravano precisamente nei giorni delle antichissime Ambarvalia (gli Ambarvali erano una serie di riti che si tenevano nell'antica Roma alla fine di maggio per propiziare la fertilità dei campi, celebrati in onore di Cerere) con i carme arvalico. Il testo del carme arvalico (verso suturnio) in lingua arcaica, divenuta incomprensibile agli stessi Romani dell'età imperiale, comprovano le remote origini del collegio. IL VERSO SATURNIO l'unico verso usato nella poesia latina arcaica, prende il nome dal dio Saturno che, secondo il mito, si era rifugiato nel Lazio dopo la cacciata dal cielo; è detto anche faunio, in onore di Fauno, il dio indigeno che lo avrebbe inventato. Il poeta Ennio scrive che gli antichi canti erano in saturni e che a questo verso ricorrevano i vati e i fauni, intendendo forse così indicare il suo uso nei canti della tradizione religiosa e agreste. È un verso imprevedibile, dalla struttura estremamente fluida sulla cui natura gli studiosi non sono unanimi: ha un ritmo quantitativo, costruito cioè secondo una precisa successione di sillabe lunghe e brevi, oppure accentuativo, basato cioè su una determinata alternanza di sillabe toniche e sillabe atone, oppure, ancora, quantitativo e accentuativo insieme. Il fatto è che nei pochi versi pervenuti, circa duecento tra epigrafici e letterari, non si riscontrano due saturni uguali. È probabile comunque che nei primi secoli il verso avesse un ritmo accentuativo di origine indoeuropea, e successivamente, in fase soprattutto letteraria, diventasse quantitativo, perché più adatto alla natura della lingua latina. CONCLUSIONI Quindi secondo la storiografia romana che, sempre di parte voleva nascondere l'esistenza della storia preromana al fine di esaltare la grandezza di Roma, Romolo e Remo, figli di una Regina e di una divinità, vennero inviati a studiare in un posto molto marginale (Gabii) presso un pastore (Faustolo) ed una prostituta (Acca Larentia). Ogni merito, per quanto avessero costruito nel futuro, sarebbe, quindi, stato solamente loro! La realtà, o meglio l'ipotesi più realistica della quale io sono convinto, è che Gabii era una antichissima città centro della socialità, della cultura e della religione pre-romana. Prima di tutto il suo legame, e forse la sua unitarietà, con Palestrina, l'antica Praeneste, la cui importanza e la cui sacralità sono testimoniate dalla collocazione su una collina difesa da una doppia cinta di mura poligonali. Un tempio, quello della Fortuna Primigenia, che, nonostante le numerose utilizzazioni successive, ha mantenuto la sua forma originale: quella di una Ziqqurat sumero-mesopotamica. Quindi una datazione che, a mio avviso, può risalire a 2000 anni prima della fondazione di Roma. Un'altra Ziqqurat è stata individuata in Sardegna e questo a testimonianza della espansione dell'antica civiltà cancellata dall'evento catastrofico che, probabilmente, attorno al 1600 A.C., ha trasformato la geografia mediterranea. L’esplosione di Thera, un meteorite precipitato, lo spostamento dell’asse terrestre o l’apertura dei Dardanelli, o meglio quello di Gibilterra, un evento distruttivo epocale, o il concatenarsi di più eventi a breve distanza di tempo, ha modificato sostanzialmente la configurazione della terra e, per quel che ci riguarda, del vecchio continente e del mar mediterraneo. Per concludere Gabii, Faustolo e, soprattutto, Acca Larentia sono i veri fondatori di Roma e i Romani che hanno cercato di nascondere tutto con una leggenda, alla fine, non hanno potuto cancellare la cosa più figurativa ed immediata: Il simbolo stesso di Roma che ancora adesso la rappresenta.